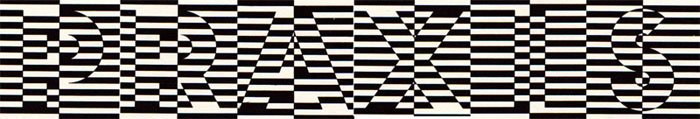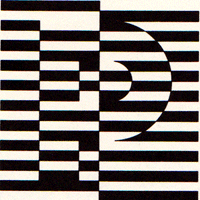Maurizio Ferraris
Che cosa si può fare con un bastone?
Anassagora non sembra avere esitazioni: l’umano è più intelligente degli altri animali per via della mano, che gli consente delle manipolazioni pratiche e di qui, con un processo che può durare millenni, lo sviluppo dell’intelligenza. In questo senso, la definizione dell’umano in Anassagora suonerebbe come: l’umano è l’animale dotato di mano. L’umanesimo sarebbe un manesimo, un poter manipolare, e disporre di maniglie, manici, mazze, missili, e ovviamente anche di monete, manuali, moleskine, e cellulari, che – con un anglismo molto espressivo – in Germania si chiamano “Handy”.
Aristotele, come sappiamo, non condivide la prospettiva di Anassagora, e non stupisce, dal momento che per lui l’umano è l’animale dotato di linguaggio, e che ama stare in società. Proprio per questo, prosegue Aristotele, è più intelligente degli altri animali, ed è come una conseguenza e non come una causa che riceve, diversamente dagli altri animali, la mano.
La presa di posizione di Aristotele ci pone di fronte a una cerimonia implausibile e favolosa, quella del conferimento della mano. Gli animali sono schierati, ognuno con le sue caratteristiche e con le sue abilità, e l’uomo con la sua socievolezza (che al momento non può esprimersi sé con strette di mano né con pacche sulla schiena) e con il suo linguaggio che gli è venuto dal cielo insieme alla sua intelligenza mostruosa. Il Dio li passa in rassegna, e, compiaciuto dell’intelligenza dell’umano, lo premia con una mano, anzi, don due.
Ci sono ottime ragioni per pensare che non sia andata così, e che Anassagora avesse ragione. Perché la visione di Aristotele suppone un momento esatto in cui l’umano avrebbe ricevuto il linguaggio, qualcosa come una pentecoste che discende dal cielo, e in cui ha deciso di mettersi in società per semplificarsi la vita (non è detto) e por fine alla guerra di tutti contro tutti (non è detto nemmeno quello).
Sono visioni ingenue e mitologiche, ma che vengono condivise anche dai nostri contemporanei che parlano senza difficoltà di “istinto del linguaggio” e di “intenzionalità collettiva”. Il primo ci permetterebbe di parlare, proprio come per i frenologi il binocolo dell’aritmetica ci permetteva di contare. La seconda sarebbe alla base del sistema di accordi e di imposizioni di funzioni da cui nasce il mondo sociale.
Ma, banalmente, se gli umani non fossero stati in grado di accendere un fuoco, il che richiede certe abilità con le mani, sarebbero mai riusciti a formare quel primo nucleo in cui, passandosi cibi (manipolati), spulciandosi a vicenda (con le mani), abbracciandosi e accoppiandosi hanno avuto inizio le prime comunità? Queste comunità erano ancora in tutto e per tutto simili a quelle del nostro passato animale, la sola differenza era la capacità di accendere il fuoco, che dipendeva dalle peculiari conformazioni delle nostre mani.
Il fuoco e il raccogliersi intorno a esso provocheranno altri sviluppi legati alla mano. Armi per colpire, attrezzi per tessere e per coltivare, e soprattutto pratiche di fabbricazione che archiviavano in se stesse i processi che le avevano costituite, dando luogo a tradizioni plurimillenarie (si pensi all’evoluzione dei manufatti di pietra scheggiata), e di qui alla nozione di tradizione e di storia, che si è manifestata anzitutto con delle rappresentazioni (dipinti, cippi e statue che evocavano eventi) e poi si è sviluppata in concetti, ed è diventata cultura, un termine che tuttavia, non dimentichiamolo, trae la propria origine dalla coltivazione, dalla manipolazione tecnica della natura.
È a questo punto che l’umano si è trovato a possedere un linguaggio e una società. Quest’ultima nasce dalla condivisione di uno spazio protetto di condivisione di beni, tanto è vero che qualunque venir meno della condivisione e della protezione (la politica ce ne dà prove infinite) genera un crollo della solidarietà sociale, sino alla rottura del patto e dichiarazione secondo cui la società non esiste, ma esistono solo gli individui. E il linguaggio si sviluppa dopo il gesto, e dopo la scrittura e la manipolazione, nelle condizioni rese possibile dall’una e dall’altra: è un risultato e non un presupposto. Nel momento in cui le mani dell’umano sono impicciate da apparati tecnici, non potrà più servirsene per esprimersi, e incomincerà a parlare, in un processo che sura centinaia di migliaia di anni e nel quale, facciamoci caso, i primi nomi indicano degli attrezzi, così come i primi cognomi delle professioni legati alla manipolazione: ferrari, calzolari, mugnai, sarti.
Non c’è nulla dentro l’animale umano che lo renda diverso dagli animali non umani. È tutto fuori. Nella mano che permette l’attrezzo, capitalizzando la forza (un bastone moltiplica il braccio) la memoria (un bastone è buono per annotare i giorni che passano facendone un calendario) la società (su due bastoni, uno del debitore e uno del creditore, se li si pongono accanto, facendo una tacca per ogni transazione, si può creare una contabilità efficiente). E nel capitale ottenuto attraverso la registrazione che si trasforma in accumulo della cultura, della ricchezza, delle risorse, che permettono l’emergere di quella caratteristica soltanto umana, perché nasce da una sovrabbondanza di risorse, che è il progetto.
Maurizio Ferraris è professore di Filosofia teoretica presso l’Università di Torino. Nelle sue ricerche filosofiche ha contribuito alla rielaborazione delle posizioni ermeneutiche e negli ultimi anni è passato dalla proposta di una ontologia critica e sociale allo sviluppo di una posizione filosofica che può essere definita “nuovo realismo”, in alternativa al postmodernismo e al pensiero debole. Dirige il LabOnt (“Laboratorio di Ontologia”) e collabora con le pagine culturali de “la Repubblica”. Dopo aver scritto e condotto “Zettel - Filosofia in movimento” per Rai Cultura, dal 2015 conduce “Lo Stato dell’Arte” su Rai 5, dedicato all’approfondimento di temi d’attualità, politica e cultura. Tra i suoi libri recenti: Goodbye Kant! Cosa resta oggi della Critica della ragion pura (Milano 2004); Dove sei? Ontologia del telefonino (Milano 2005); Sans papier. Ontologia dell’attualità (Roma 2007); Il tunnel delle multe. Ontologia degli oggetti quotidiani (Torino 2008); Piangere e ridere davvero. Feuilleton (Genova 2009); Ricostruire la decostruzione (Milano 2010); Estetica razionale (Milano 2011); Filosofia per dame (Milano 2011); Anima e iPad (Milano 2011); Manifesto del nuovo realismo (Roma-Bari 2012); Realismo positivo (Torino 2013); Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce (Roma-Bari 2014); Spettri di Nietzsche (Milano 2014); L’imbecillità è una cosa seria (Milano 2016); Postverità e altri enigmi (Milano 2017); Il denaro e i suoi inganni (con J.R. Searle, Torino 2018).
_________________________________________________________________________
Silvia Vizzardelli
L’atto teleplastico: le sagome del pensiero
Non occorrono mani per plasmare corpi. Esiste un’attitudine plastica del pensiero e del linguaggio che non si serve della diretta manipolazione, non fa rotolare materie raccolte nel mondo per dar loro forma, ma si fa corpo. Il pensiero è capace di una diffusa plasticità e tattilità fantasmatica, al punto che, potremmo dire, i pensieri si vedono, si toccano, si plasmano con strane mani: le mani di un tatto interno, che coincidono con la superficie del pensiero, raccolto, ripiegato, chiuso a formare l’involucro di se stesso: una mano perimetrale, una mano-cute. C’è un pensiero nel pensiero, una voce nella voce, una parola nella parola che danno corpo, tridimensionalità a ciò che, in prima battuta, sembrerebbe disciogliersi nell’evanescenza diacronica di una successione impalpabile. C’è qualcosa di inesorabile, di consistente, di fissato, di materico nel pensiero, una sorta di nous aptico in cui circola trionfante Eros. Ecco perché non riusciremo a tener distinti pensiero e godimento. Nel pensiero, nelle parole, si annida, si imbozzola il godimento, e non si dà jouissance che non sia un prender corpo. Per far questo, occorre posizionarsi in un regno intermedio tra bisogno e desiderio, che è precisamente il regno del godimento e delle figure fantasmatiche: il godimento non ha l’inquietudine dell’inesauribile apertura all’alterità, perché si nutre di materializzazioni, fissazioni, idoletti, forme, spettri, ma non ha nemmeno la chiusura che la soddisfazione apporta al bisogno. E’ una corpsistenza, per riprendere un neologismo lacaniano, un prender-corpo che non si lascia catturare dalle smanie del possesso. Ecco è, forse, proprio questa la struttura del fantasma: un prender-corpo non irretito dall’uso e dal possesso, non afferrabile e capitalizzabile. Proprio come accade agli spettri: figure plastiche che, però, non possiamo raccogliere e custodire e che, se possiamo toccare, ciò accade grazia ad una sorta di tatto interno.
Nel pensiero contemporaneo, il concetto di plasticità viene perlopiù utilizzato per alludere alla capacità trasformativa dell’uomo, alla facoltà di rigenerarsi in un morphing fluido e continuo a discapito della permanenza e fissazione delle scritture. Penso in particolare al lavoro di Catherine Malabou che contrappone l’evanescenza trasformativa della plasticità al carattere permanente dell’iscrizione. Scopo del mio intervento sarà quello di mostrare come, per comprendere l’atto teleplastico, non si possa prescindere da quella che chiamerei degustazione della forma chiusa. E’ in questa ripiegatura gustativa che si rivela la familiarità di ogni nostro pensiero col godimento. Il godimento evoca una sorta di tornitura, di sagomatura intorno al farsi di un corpo.
Silvia Vizzardelli (Torino 1967) ha conseguito il Dottorato di ricerca in Estetica presso l’Università di Bologna nel 1999, con una tesi sulla musica nell’estetica di Hegel. È Professore associato di Estetica nel Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria dal 2006. E’ membro della Società Italiana di Estetica (SIE). E’ capofila di un progetto interuniversitario di nome Skia. Estetica e psicoanalisi volto ad organizzare, tra le altre cose, una Summer School dedicata al tema della visione fantasmatica. Collabora col quotidiano Il Manifesto e il suo settimanale Alias. Il suo ambito di ricerca comprende i rapporti tra estetica e teoria delle arti, e ha dato ampio sviluppo ai temi connessi alla filosofia della musica. Da qualche anno si occupa del rapporto tra estetica e psicoanalisi. Tra le sue pubblicazioni in volume: L’esitazione del senso. La musica nel pensiero di Hegel (Roma: Bulzoni 2000); a cura di, La regressione dell’ascolto. Forma e materia sonora nell’estetica musicale contemporanea (Macerata: Quodlibet 2002); Battere il tempo. Estetica e metafisica in Vladimir Jankélévitch (Macerata: Quodlibet, 2003); Filosofia della musica (Roma-Bari: Laterza 2007); Verso una nuova estetica. Categorie in movimento, (Milano: Bruno Mondadori 2010); con Felice Cimatti, a cura di, Filosofia della psicoanalisi, Un’introduzione in ventuno passi (Macerata: Quodlibet 2013), Un canto, un corpo. Teorie romantiche della musica (Il Glifo ebook, 2013); Io mi lascio cadere. Estetica e psicoanalisi (Macerata: Quodlibet); La tentazione dello spazio. Estetica e psicoanalisi dell’inorganico (con V. De Filippis, Orthotes 2017); con M. Bonazzi, C. Serra, a cura di, Voce. Un incontro tra filosofia e psicoanalisi, (Mimesis 2018).
_________________________________________________________________________
Gaetano Rametta
Filosofia trascendentale e pensiero contemporaneo
Introduzione alla filosofia trascendentale. Breve storia del concetto nella filosofia classica tedesca: dall'Io penso di Kant alla Vita assoluta di Fichte: de-soggettivazione del trascendentale e ridimensionamento della coscienza. Il trascendentale nel contemporaneo: il pensiero di Deleuze, dall'empirismo trascendentale a "Che cos'è la filosofia"; implicazioni etiche e politiche.
Sull'avvenire della filosofia
Gaetano Rametta insegna Storia della filosofia all'Università di Padova. Ha scritto monografie su Hegel, Fichte e Bradley. Nei suoi testi dell'ultimo decennio, ha cercato di mostrare l'importanza della filosofia trascendentale per il pensiero contemporaneo.
_________________________________________________________________________
Après-coup
Daniele Poccia
La libertà dell'errore: l'epistemologia storica e la Critica del giudizio
Alessandra Campo
L'atto libero in Spinoza e Kant
Per la breccia al criticismo e la trasgressione dell’interdetto su cui si fonda (“all’ente finito non è data intuizione intellettuale”), non è necessario attendere il 1790. Già nel cuore della seconda Critica l’intuizione bandita sin dai tempi della Dissertatio torna a far capolino in un punto preciso: il Faktum della ragione. Kant è convinto che solo la voce bronzea del dovere può evocare la maestà della legge senza infrangere il suo imperscrutabile mistero e, nondimeno, è proprio questa voce che, nella terra della morale, comanda l’impossibile: dedurre l’ontico dall’epistemico. Il dovere, è vero, fornisce alla ragione il suo punto archimedeo - la libertà -, ma glielo fornisce in un modo bizzarro nel quale si fa fatica a non riconoscere l’argomento ontologico così caro agli “entusiasti” che, servendosene, si macchiavano, davanti agli occhi di Kant, di una colpa indelebile. Nello specchio offertole dall’idea cosmologica di libertà la ragione si scopre, infatti, legislatrice ed esecutrice a un tempo, contemplativa e attiva, recettiva e spontanea, perché quando il velo dell’interdetto cade, anche se solo per un attimo, l’idealismo critico appare per quello che è: un esercizio debitamente trascendentale e debitamente realistico, nient’altro che un atto libero.
__________________________________________________________________________
LabOnt
Erica Onnis
Libertà e determinismo. Un falso dilemma.
Il termine “determinismo” può essere inteso in almeno due modi. Il primo è un determinismo causale, secondo il quale tutto ciò che accade nell’universo sarebbe causalmente necessitato da stati a esso precedenti in virtù di ferree leggi di natura. Questo tipo di determinismo è diacronico e può essere visto come un determinismo “orizzontale” che definisce lo sviluppo e le dinamiche di stati-di-cose o processi.
Il determinismo può essere alternativamente inteso in forma “verticale”, come un tipo di determinazione costitutiva sincronica, secondo cui la natura dei fenomeni macroscopici (le pietre, i tavoli o le persone), sarebbe determinata dalle proprietà delle loro parti costituenti (gli atomi, le molecole o le cellule). Questa forma di “micro-determinismo” può essere correlata all’atomismo, secondo cui la realtà sarebbe composta da alcuni tipi di mattoncini fondamentali in grado di aggregarsi e comporre le diverse entità che popolano il mondo determinandone le proprietà e governandone il comportamento.
Così come li abbiamo enunciati, sia il determinismo causale sia il micro-determinismo rappresentano una minaccia per l’autonomia delle entità macroscopiche e, di conseguenza, dell’agire umano. Essendo l’uomo parte del mondo, avendo esso alle spalle un certo passato ed essendo infine soggetto alle leggi naturali, la possibilità che l’agire umano sia “libero”, ossia solo parzialmente determinato dal passato e dalle leggi di natura, pare metafisicamente esclusa.
Tiziana Andina
Atto libero: i vincoli dell'arte
L’opera d’arte è davvero frutto di un atto libero? L’arte contemporanea pone molte questioni interessanti alla filosofia: in sede ontologica assistiamo alla decontrazione della ontologia classica; inoltre, gli artisti dopo aver diligentemente decostruito i paradigmi più noti, nel corso del Novecento paiono essersi liberati da qualsiasi vincolo normativo. Ma è davvero così?
Cercheremo di mostrare come questa assenza di normatività sia soltanto illusoria e come di fatto le arti contemporanee abbiano sviluppato una ontologia e una normatività diverse da quelle tradizionali aprendo in questo modo nuove possibilità per le arti.
___________________________________________________________________________
Philosophy Kitchen
Dopo la struttura. Stili e voci di un’enciclopedia dei saperi
Da cosa nasce l’atto del pensiero? E, soprattutto, da cosa nasce la creatività che quell’atto caratterizza? Certo dalla plasticità cerebrale; ma, non meno, dal fatto che ogni atto di pensiero del soggetto presuppone una dipendenza da reti di saperi più vaste, sussumibili sotto il concetto di enciclopedia. In tale incontro si esploreranno alcuni aspetti di questo intreccio, mostrando il modo in cui i saperi si costituiscono, sia come entità storico-istituzionali dipendenti dal nesso tra verità e potere; sia come entità pertinenti la dimensione categoriale, del tutto autonoma, eppure al contempo decisiva rispetto a quel non ancora attuale che si dà come evento.
____________________________________________________________________________
Centri di ricerca
LabOnt
Fondato nel 1999, e già afferente al Dipartimento di Filosofia, il LabOnt (laboratorio di Ontologia) è un centro di ricerca specializzato in ontologia sociale e in estetica (cfr. sul sito ufficiale la sezione LabOnt Art). Diretto, sin dalla sua fondazione, da Maurizio Ferraris, il centro comprende a oggi 7 professori e ricercatori, 4 postdoc, 6 dottorandi e 9 membri associati. Scopi prioritari sono lo sviluppo e il coordinamento della ricerca, la formazione di giovani ricercatori, l’organizzazione di convegni e di workshop, la diffusione dei risultati delle ricerche dei suoi membri attraverso pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale e internazionale. Il gruppo di ricerca afferente al Labont ha collaborato alle attività di numerosi PRIN (Progetti di Ricerca di rilevante interesse Nazionale), sotto la coordinazione nazionale di Maurizio Ferraris.
Philosophy Kitchen
è una rivista di filosofia fondata da un gruppo di giovani studiosi dell'Università degli Studi di Torino, che lavorano sotto la supervisione del prof. Giovanni Leghissa. Il nostro intento principale è quello di creare le condizioni ottimali per uno spazio di riflessione filosofica che sia in grado di ospitare, nello stesso tempo e in maniera incondizionata, spunti fecondi provenienti dalle più diverse aree del sapere. Qui, fenomenologia, decostruzione, teoria dei sistemi, filosofie della vita, filosofia del diritto e della giustizia, filosofie interculturali, antropologia filosofica, psicoanalisi e molto altro ancora, troveranno terreno fertile per mettere radici, ma, soprattutto, per fare rizoma.
Après-coup
Il centro studi Après-coup nasce nel 2014 presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila su iniziativa di Rocco Ronchi, Alessandra Campo e Daniele Poccia con l'obiettivo di riflettere sulla rilevanza filosofica della concettualità psicoanalitica. Nel corso degli anni ha promosso una serie di iniziative sui temi comuni alla pratica psicoanalitica e alla pratica filosofica rivolgendo una particolare attenzione al rapporto della psicoanalisi con la fenomenologia, con l'epistemologia della complessita e con l'"empirismo" bergsoniano e deleuziano.
►
direzione della scuola Rocco Ronchi
organizzazione Masque teatro
PRAXIS
Info ed iscrizioni
info@praxis-scuoladifilosofia.eu
Masque teatro - 393.9707741
sede dei corsi
Sala Nassirya - Palazzo ex-Tribunale, Piazza G.B. Morgagni n.2, Forlì
|